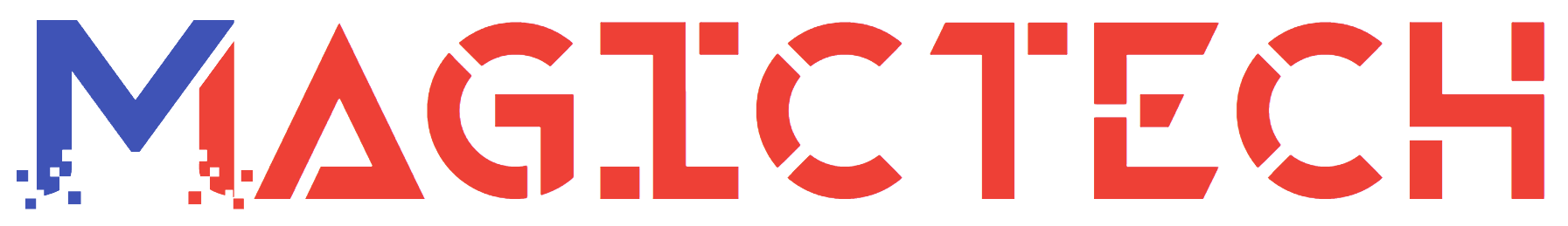Azioni, obbligazioni, gilt indicizzati a lungo termine, credito, criptovalute: l’elenco delle storie dell’orrore del mercato nel 2022 è ampio. Eppure la più grande vittima di quest’anno è stata sicuramente la reputazione delle grandi banche centrali.
Nel periodo dall’inizio della pandemia di coronavirus e dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, le loro previsioni sull’inflazione sono state desolatamente fuori raggio. La loro risposta al rapido aumento del livello dei prezzi è stata lenta e, nel caso degno di nota della Federal Reserve statunitense, inizialmente timorosa.
La saggezza convenzionale delle banche centrali sosteneva che fosse necessario “esaminare” gli shock dal lato dell’offerta come gli aumenti dei prezzi del petrolio e del gas e le chiusure di porti e impianti di semiconduttori perché il loro impatto sulla produzione potenziale era transitorio.
Eppure è chiaro che gli shock dell’offerta e l’inflazione derivanti da fattori come la deglobalizzazione determineranno una riduzione duratura della produzione potenziale. In tali circostanze, è compito dei responsabili della politica monetaria inasprire in modo che la domanda sia allineata alla ridotta capacità produttiva. Una delle lezioni dell’inflazione spinta dai costi degli anni ’70 dopo il primo aumento del prezzo del petrolio è stata che gli shock dal lato dell’offerta possono anche, nel gergo dei banchieri centrali, disancorare le aspettative di inflazione e produrre effetti di secondo impatto sui mercati del lavoro.
I recenti errori di politica monetaria possono in parte riflettere una perdita di memoria generazionale collettiva. Pochissimi banchieri centrali di oggi erano sulle barricate per combattere l’inflazione dopo gli shock petroliferi degli anni ’70. Anche l’eccesso di fiducia dopo decenni di bassa inflazione è stato senza dubbio un fattore. Per quanto riguarda la timida mossa iniziale di restringere la politica, va detto in tutta onestà che è notoriamente difficile valutare un output gap in tempo reale.
Lael Brainard, vicepresidente della Fed, punti alla prolungata sequenza di shock all’offerta di lavoro, merci e input critici come i semiconduttori. Ciò ha offuscato i confini tra ciò che costituisce uno shock temporaneo e uno persistente per la produzione potenziale.
Il risultato di tutto ciò è che le banche centrali hanno perso autorità. Allo stesso tempo, il loro tardivo inasprimento delle politiche sta danneggiando i loro stessi bilanci perché l’aumento dei rendimenti sta infliggendo grosse perdite mark-to-market agli enormi portafogli obbligazionari acquisiti dalla crisi finanziaria del 2007-09.
Non tutte le banche centrali riporteranno queste perdite – c’è una notevole variazione nella pratica di segnalazione. Molti sosterranno che non sono istituzioni che massimizzano il profitto e possono operare perfettamente con un patrimonio netto negativo. Non possono fallire perché possono stampare denaro.
Tuttavia, può esserci un punto critico in cui i mercati temono che la debolezza finanziaria porti a un’inflazione elevata o iperinflazionata. Rivolgersi ai ministeri delle finanze per il capitale potrebbe ridurre l’indipendenza che le banche centrali conservano dopo la crisi finanziaria. (Ciò non si applica, per inciso, alla Banca d’Inghilterra, che ha chiesto e ottenuto un indennizzo dal Tesoro contro le perdite della crisi.)
L’incertezza che circonda la condizione delle economie avanzate è tale che esiste il rischio sia di eccesso che di difetto monetario. Un passaggio alla recessione nel 2023 potrebbe esporre le fragilità finanziarie derivanti dal lungo periodo di tassi di interesse estremamente bassi in cui gli investitori hanno cercato rendimento indipendentemente dal rischio.
L’ipotesi di lavoro tra i banchieri centrali è che dalla crisi i bilanci delle banche si sono rafforzati, ma che il rischio è migrato al settore finanziario non bancario. C’è qualcosa in questo, come ha dimostrato l’aumento della leva finanziaria nel sistema pensionistico del Regno Unito che è stato rivelato durante la crisi dei gilt di settembre.
Ma ci sono anche grandi e molto poco trasparenti rischi fuori bilancio sia nel settore finanziario bancario che in quello non bancario, in particolare in relazione al debito in dollari in operazioni di swap, contratti a termine e swap su valute. In un carta per la Banca dei Regolamenti Internazionali, Claudio Borio, Robert McCauley e Patrick McGuire sottolineano che 85 trilioni di dollari di obbligazioni in essere per pagare dollari in questi strumenti superano lo stock di buoni del tesoro in dollari, contratti di riacquisto e carta commerciale messi insieme.
Le obbligazioni, che sono aumentate notevolmente dopo la crisi finanziaria, sono per lo più a brevissimo termine e spesso comportano disallineamenti di scadenza in istituzioni come assicurazioni e fondi pensione. Le conseguenti esigenze di rollover comportano una contrazione dei finanziamenti in dollari, come è accaduto durante la crisi finanziaria e nel marzo 2020 all’inizio della pandemia. Questi obblighi di pagamento in dollari non compaiono nei bilanci e mancano nelle statistiche standard sul debito. La portata dei problemi qui è ovvia.
Per il momento, una visione di mercato standard è che il mantra “più stretto più a lungo” delle banche centrali manterrà i rendimenti obbligazionari in aumento e le azioni in calo. Ma la grande domanda è se, in caso di crisi dei finanziamenti, le banche centrali si sentiranno nuovamente obbligate a tornare ad acquistare asset per sostenere i mercati e le istituzioni finanziarie, indebolendo così la loro posizione antinflazionistica.
Una simile inversione a U equivarrebbe a un revisionismo della banca centrale di prim’ordine; in effetti un ritorno a una politica monetaria asimmetrica moralmente rischiosa. La cosa preoccupante è che è fin troppo plausibile.