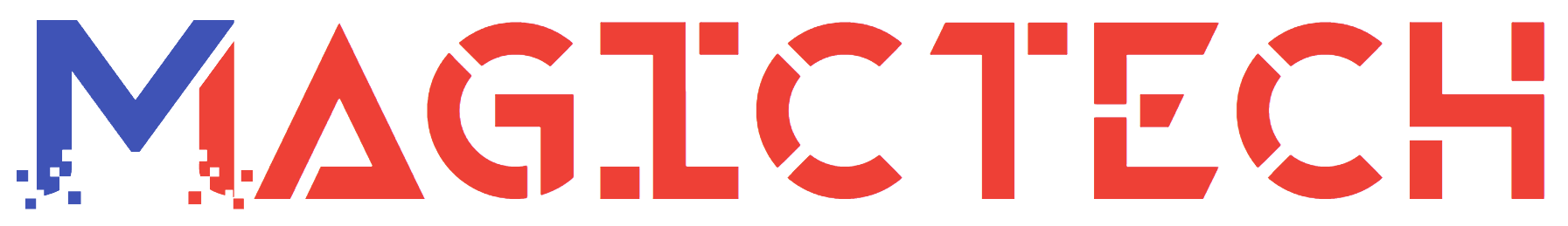Durante la pandemia, le banche centrali degli Stati Uniti e della zona euro hanno riformato la loro strategia di politica monetaria in una rottura sostanziale con la pratica precedente. Dopo un decennio di inflazione al di sotto dell’obiettivo e l’occupazione che ha impiegato molto tempo per tornare ai massimi precedenti, i decisori dei tassi di interesse hanno promesso di essere rilassati sull’aumento dell’inflazione temporaneamente al di sopra dell’obiettivo fintanto che lo stimolo monetario in corso fosse stato altrimenti giustificato.
Ciò avrebbe dovuto rafforzare i nervi dei banchieri centrali di fronte a diverse brutte sorprese dal lato dell’offerta. E per un po’ hanno mantenuto la calma durante lo scoppio inflazionistico che ne è derivato. Ma non hanno sostenuto il coraggio delle loro nuove convinzioni. Invece hanno lasciato che le critiche li costringessero a rifiutare la possibilità che un’elevata pressione della domanda potesse attirare nell’economia più risorse di quanto si pensasse in precedenza e quindi nel tempo aiutare a contenere le pressioni sui prezzi mantenendo la crescita.
Le banche centrali ora sembrano determinate a ripristinare quella versione monetaria del machismo tossico che dice che se non fa male, non funziona. I leader politici sono sempre più espliciti sull’intenzione di ridurre l’inflazione anche a costo di rallentare la crescita o di licenziare le persone. I mercati hanno preso spunto e si stanno preparando alla recessione.
I banchieri centrali non ne traggono piacere, ovviamente. Il loro caso si basa sul pensare che non ci sia alternativa migliore. Ma se è così, è meglio che abbiano assolutamente ragione e sfortunatamente la loro argomentazione è più debole di quanto molti pensino.
All’inizio l’aumento dell’inflazione è stato quasi universalmente attribuito a shock dell’offerta. Ma nonostante l’ovvio ruolo dell’attacco di Vladimir Putin all’Ucraina e il conseguente inasprimento delle forniture di gas, l’opinione prevalente si è in qualche modo spostata sull’incolpare la domanda eccessiva.
Eppure è solo quest’anno che la spesa nominale ha superato la tendenza pre-pandemia negli Stati Uniti; e ancora non lo ha fatto nel Regno Unito o nella zona euro. Anche negli Stati Uniti, il volume totale di beni e servizi acquistati (in contrapposizione al loro valore di mercato) è in linea con il trend pre-pandemia. Non tanto la domanda impazzita, quindi, quanto il recupero della domanda (a sua volta un trionfo della definizione delle politiche di crisi) di fronte all’aumento dei prezzi per ragioni dal lato dell’offerta.
L’ovvia replica è che, anche se la domanda è vicina a un livello normale, l’offerta potrebbe non esserlo, a causa della pandemia o dei picchi di prezzo dell’energia e delle materie prime. Ma quanto possiamo essere certi che si tratti di problemi durevoli? (Non ha molto senso provocare una recessione per far fronte a singhiozzi temporanei nell’offerta.)
La pandemia avrebbe potuto danneggiare la capacità produttiva dell’economia riducendo il numero di lavoratori sani. Ma non nella zona euro, dove molti paesi registrano tassi di occupazione record. E mentre l’economia statunitense impiega ancora quasi un milione di persone in meno rispetto a febbraio 2020, l’attuale boom continua ad aggiungere posti di lavoro a tassi più del doppio della media pre-pandemia. La crescita dell’occupazione resta forte anche nell’Europa continentale.
Ci sono pochi segni di questo svanire. Ma le banche centrali potrebbero arrestarlo con la loro determinazione a ridurre la crescita della domanda. Quindi sorge la domanda: ciò di cui le nostre economie hanno più bisogno ora è davvero avere meno persone al lavoro? Anche con la lente dell’inflazione, lasciare che l’occupazione e quindi l’offerta continuino a crescere fortemente non è ciò che è necessario per ridurre in modo sostenibile le pressioni sui prezzi?
Lo stesso vale per la crisi energetica. Per le economie importatrici nette di energia, i prezzi elevati di petrolio, gas ed elettricità le rendono più povere, quindi dovranno esportare di più e consumare di meno per soddisfare il loro fabbisogno energetico. Come si risolve questo problema riducendo anche la propria produzione, quando la politica restrittiva colpisce sia l’occupazione che gli investimenti? (Per quanto riguarda i paesi che non sono importatori netti, l’aumento dei prezzi dell’energia causa disuguaglianza che la stretta monetaria può solo peggiorare.)
L’ultima linea di argomentazione a favore dell’inasprimento in una recessione innescata dall’offerta è quella di evitare una spirale salari-prezzi. Ma la razionalità di ciò dipende dal fatto che il rischio è più che teorico. Di per sé, gli aumenti salariali sono ovviamente qualcosa da accogliere e i robusti margini di profitto suggeriscono che i costi salariali non stanno facendo salire i prezzi. Vale anche la pena notare che i paesi con la maggiore copertura della contrattazione collettiva (Francia, Italia, Paesi nordici) hanno i tassi di inflazione più bassi.
Niente di tutto ciò dovrebbe sminuire la vera sofferenza causata dalla crisi del costo della vita. Ma la contrazione monetaria sull’apice di una recessione peggiorerà le cose senza alcun beneficio. I governi devono mettere in atto un sostegno per coloro che sono stati maggiormente colpiti dal balzo dei prezzi. Ma forse le banche centrali, proprio nell’interesse della stabilità monetaria ed economica, dovrebbero trattare l’inflazione con più benigna negligenza.